Ubik

Ubik (1966) by Philip K. Dick
Ubik viene scritto alla fine degli anni 60, nel 1966, anni nei quali l’autore scrive molte delle sue opere ritenute migliori, tra le quali: The Three Stigmata of Palmer Eldritch (1965), Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968) e altre ancora.
E' ritenuto pressochè la summa della narrativa di Dick e il suo capolavoro e non a caso.
E’ un libro sconcertante: Dick si diverte a scagliarci da un incubo allucinatorio all’altro, con una ironia nerissima e una vena quasi comica e sardonica.
Con Ubik P. K. Dick riesce a condensare tutta una serie di sue ossessioni personali, rendendole però universali.
Questa è una delle grandezze degli scrittori che riescono a parlare a tutti parlando in realtà di se stessi.
Dopo una prima parte nella quale dispone i personaggi e le pedine sulla scena, il racconto si dispiega come un normale romanzo di Sci-Fi, ambientato in un 1992 nel quale si danno battaglia società commerciali che raccolgono uomini e donne con talenti PSI e altre che si devono occupare di annullarne i poteri in una sorta di bilanciamento.
Gia in questa parte riconosciamo alcune tematiche decisamente interessanti, ad esempio la modalità peculiare con la quale le persone in fin di vita possono essere congelate in uno stato di semi-vita attraverso il quale possono essere richiamati a parlare con i parenti. Ma anche alcune temi tipici di Dick: il protagonista (autobiograficamente) sempre in bolletta, sfigato, perseguitato da un destino bizzarro, incapace di relazionarsi con le donne che invariabilmente o sono dark lady (sempre coi capelli scuri) sfuggenti e vessatorie o eteree figure materne.
Poi ci sono il ruolo pervasivo della pubblicità e un capitalismo, una mercificazione che si insinua in ogni più piccolo aspetto della quotidianità con macchine che si rifiutano di fare quello che devono se non costantemente pagate, porte che non si aprono se non si inseriscono soldi e via dicendo.
Infine la guerra di spionaggio industriale tra corporazioni con l’uso spregiudicato di persone con capacità psioniche che sconfinano nell’omicidio e in attentati.

Tutto questo ha una sua coerenza e linearità -anche se non mancano squarci inquietanti: dalle presenze invasive che si presentano a Runciter durante i colloqui con la moglie, ai poteri difficili da definire, di Pat (guardacaso stesso nome di una altrettanto potentissima Psi nei “Giocatori di Titano”) fino alla disastrosa missione sulla Luna.
Da lì in poi la realtà comincia a dare segni di cedimento, di decadimento. Joe Chip, il protagonista - che già nel cognome manifesta la sua caratteristica di squattrinato (cheap) - insieme ai dipendenti con poteri psionici assoldati da Glenn Runciter vengono scagliati in un viaggio sempre più allucinatorio.
Viaggio che per certi versi è una “quest” classicissima ma che si fatica a comprendere fino in fondo.
Il tutto viene mescolato assieme a salti temporali che appaiono quasi come una realtà sottostante che si manifesta in modo apparentemente casuale rispetto a quella sovrastante (si richiamano direttamente i concetti di sovrastruttura e struttura).
Alcuni personaggi muoiono orribilmente apparentemente consumati dal tempo, senza un perché mentre altri si fanno costanti domande che riguardano il costrutto stesso dell’esperienza che stanno vivendo.

“Io sono vivo e voi siete morti” trovano scritto sui muri di un bagno. E messaggi “esterni” a loro diretti compaiono in oggetti in modo apparentemente casuale: una etichetta, una scatola di fiammiferi, il verbale di una multa.
Domande che alla fine troveranno (almeno in parte) una loro terribile risposta. Comunque messa in discussione nella paginetta dell’ultimo capitolo in un post-finale che rimette di nuovo tutto in movimento.
C’e’ la lotta continua contro questo decadimento, questo invecchiamento, questa fatica, una oppressione continua con improvvise e capricciose accelerazioni e contro la quale non si può nulla se non ricorrere a una mitologica sostanza chiamata Ubik, una specie di ricostituente salvifico che è anch’esso un rimedio totalmente inventato, auto-generato all’interno di un questo mondo che si auto-sostiene e si auto-legittima.
Sostanza e materia, forse Dio.
In questo spazio si dispiegano forze benigne e maligne in una lotta costante e perpetua. Dualismo bene/male, divino/terreno anch’esso pregnante e presente che si materializza nella figura paterna di Runciter e in quella della maschera folle di Jory. Il quale si nutre della vita altrui ingurgitandola in un continuo bisogno di espansione che ci riporta direttamente alle fusioni e acquisizioni delle grandi corporazioni.
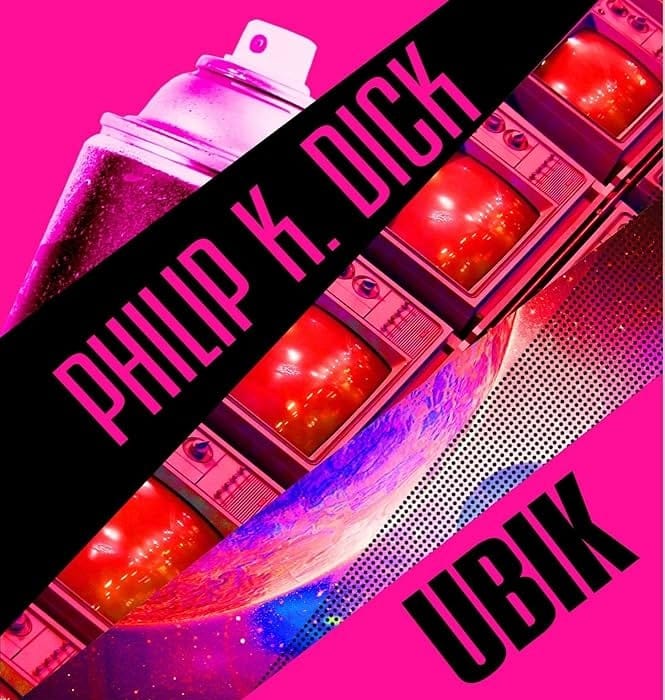
Se in “Gli androidi sognano pecore elettriche?” la forza disgregatrice era la “palta”, qui ci troviamo in lotta con una medesima forza disgregatrice che è il tempo stesso e in definitiva l’entropia universale (e quindi la morte).
La scena nella quale Joe lotta disperatamente contro questa forza su una rampa di scale è la descrizione terribile ma magnifica della ribellione della volontà rispetto a questo decadimento invincibile.
Scena, questa, che riporta alla mente la parabola cristologica della salita al Golgota di Mercer in “Do Androids Dream of Electric Sheep?” nel quale ogni gradino diventa uno sforzo impossibile e una sofferenza indicibile.
[…] Con la chiave ancora in mano, cadde; la testa colpì la porta e cadde a corpo morto sul tappeto impregnato di polvere, inalando l’odore dell’età e della spossatezza e della morte frigida. Non posso entrare nella stanza, si rese conto. Non posso più alzarmi in piedi. Eppure doveva farlo. Qui potevano vederlo.
Stavolta più che il senso mistico della salita di Mercer, c’e’ la fatica di Sisifo, una lotta impari che pure deve essere condotta fino alla fine. La’ dove si trova solo la morte. Tutta l’insensatezza e la fatica del vivere condensata in poche pagine nella quale fa capolino anche la ricerca della solitudine nel momento supremo, come fanno gli animali morenti.
A questo va aggiunto il gusto quasi cinico e satirico in bilico tra le ossessioni kafkiane e gli incubi di Borges.

Anche qui troviamo il tema della droga come terapia: le anfetamine utilizzate come stimolanti usati dai protagonisti per poter superare la stanchezza e proseguire nel racconto. Un altro elemento tipico, quello delle droghe sintetiche utilizzate nei romanzi di Dick.
Nel libro trovano spazio poi i soliti squarci di futuro con scene che sembrano uscite dritte dall’immaginario filmico di anni molto più recenti come la scena al rallentatore nel quale il farmacista lascia una scia di se stesso, una descrizione precisa e fervida di immagini ormai quasi abusate nel linguaggio cinematografico. E in fondo che cosa è quella specie di interconnessione che collega questi semi-vivi tra di loro, in una specie di rete neurale, se non proprio una specie di proto-internet, di mega rete interconnessa in nuce e in potenza?
Alla fine del romanzo le domande più importanti non ottengono risposta, le poche risposte che abbiamo nel libro ci danno un riferimento ma dietro l’ultima pagina c’e’ sempre una truffa, una realtà traballante e con poche speranze di riuscire a capire, in un costante inganno del cosmo contro la mente razionale umana.

E in definitiva è questo che penso ci rimanga di un romanzo che insinua tantissime suggestioni e ci spinge a interrogarci senza sosta. L’uomo è in costante ricerca, non può farne a meno, nonostante lotti sempre contro forze impari contrarie. Nel fare questo crea continuamente gabbie e altri inganni in un sistema sociale dove domina lo squallore, dominato dalla mercificazione costante.
Cosa è Ubik non lo sapremo mai, dal sacro unguento guaritore, allo spray disvelatore, una essenza dalle caratteristiche pop e univoche che è ovunque e da nessuna parte. Che ha il dono dell’ubik-uità appunto. Ma Ubik è lo stesso autore (u-D-ick?) che si interroga sulla sua vita e crea questa grande parabola allucinatoria per descriverla.
E’ tutto e niente e in questo sta la sua grandezza.
Ci interroga, ci scruta da pagine scritte tanti anni fa da una fantasia inquieta per certi versi premonitrice.
Che ci affascina tutt’ora.



